Una guida tecnico-divulgativa al modello EqForecast.
Autore: Stefano Calandra, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5324-2298
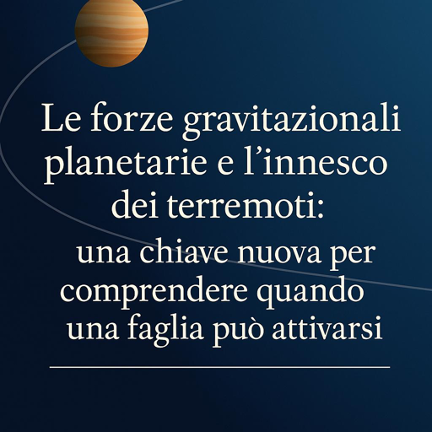
1. Introduzione: una nuova chiave di lettura per il rischio sismico
Cosa fa scattare un terremoto? Non basta sapere dove si trova una faglia attiva, o quanto stress si sta accumulando nel sottosuolo.
Serve anche capire quando questa energia può essere rilasciata. Il modello EqForecast propone una chiave di lettura originale e supportata da dati astronomici e geofisici: il momento dell’innesco sismico può essere legato a forze gravitazionali esterne, generate non solo dalla Luna e dal Sole, ma anche dai sette pianeti del Sistema Solare. Queste forze agiscono su larga scala, ma con effetti localizzati quando la crosta terrestre si trova in condizioni critiche. Le forze gravitazionali non provocano direttamente un terremoto, ma possono agire come miccia finale in un sistema geologico già instabile. La loro azione si concentra in particolare sotto forma di forze mareali che agiscono in due direzioni principali: una orizzontale, lungo la superficie Terrestre e una verticale, perpendicolare alla crosta. È quest’ultima componente, quella verticale, che secondo il modello EqForecast può costituire il vero “grilletto” dell’evento sismico.
2. Le forze planetarie coinvolte e quando diventano pericolose
Il cuore del modello EqForecast si basa sull’analisi della forza gravitazionale risultante, generata da Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno.
La configurazione più efficace (definita “linea 3”) esclude temporaneamente Sole e Luna per migliorare la coerenza statistica con una curva teorica polinomiale osservata (Calandra & Teti, 2024)¹. Questo non significa che Sole e Luna non siano importanti, ma che la modellizzazione è più pulita e regolare quando si escludono questi due corpi celesti, la cui influenza è più instabile su scala locale.
In questo primo studio, si calcola la forza gravitazionale che ogni coppia di pianeti esercita su un punto della crosta terrestre, analizzandone poi la sua variazione σ (sigma) nelle finestre temporali di 24 e 48 ore (Parametri B e A, nello studio). È importante chiarire che EqForecast non considera la forza gravitazionale assoluta esercitata dai singoli pianeti, poiché questa, da sola, risulta insignificante per muovere una faglia. Un terremoto, infatti, rilascia energie enormemente superiori a quelle esercitabili da qualsiasi corpo celeste singolo (ad esempio, un terremoto di magnitudo 6 libera circa 10¹⁵ joule, mentre l’energia esercitata dalla Luna è appena 0,00003 joule, sufficiente per sollevare solo 1 milligrammo per un metro). Lo studio, dunque, prende in considerazione solo la variazione temporale relativa della forza gravitazionale risultante, che si è dimostrata statisticamente correlata agli inneschi sismici. Sono state osservate forti correlazioni tra inneschi sismici e momenti in cui la forza gravitazionale risulta:
– estremamente stabile (variazione σ molto bassa, dove σ è il simbolo della deviazione standard, cioè l’indicatore della stabilità della forza nel tempo), oppure
– fortemente instabile (variazione σ molto elevata). In entrambi i casi, la crosta può essere sottoposta a una sollecitazione anomala che altera lo stato di equilibrio di faglie già stressate.
3. Come si accumula l’energia di un terremoto e come può innescarsi
Secondo Doglioni et al. (2020)², le forze mareali orizzontali, esercitate principalmente da Sole e Luna, contribuiscono nel lungo periodo all’accumulo di stress tettonico nelle faglie. Questo stress corrisponde a energia potenziale elastica, accumulata gradualmente dalla deformazione delle rocce. Le zolle si muovono, si scontrano e si trascinano, ma le faglie rimangono bloccate a causa dell’attrito, accumulando energia nel tempo.
Il modello EqForecast integra questa visione con il ruolo della componente verticale delle stesse forze mareali, che agisce come fattore scatenante. Questa componente verticale interverrebbe nel momento di massima stabilità o instabilità, calcolata su finestre temporali di 24-48 ore, della forza gravitazionale risultante esercitata dai sette pianeti del Sistema Solare. Le forze verticali non accumulano energia lentamente ma operano come elemento scatenante (trigger), modificando la pressione normale lungo la faglia e favorendo così l’innesco sismico. Quando una faglia è prossima alla soglia critica di rottura, anche una piccola variazione della pressione normale sul piano di faglia può rompere l’equilibrio statico, trasformando l’energia potenziale accumulata in energia cinetica. È importante sottolineare che non conosciamo esattamente lo stato energetico di una faglia, cioè la condizione sufficiente per prevedere con certezza tempo e luogo del terremoto. A tale proposito, il modello Previsio sviluppato dal geologo Giulio Riga cerca proprio di calcolare questa soglia energetica critica per numerose faglie in Italia (Riga, 2015)³.
Non potendo misurare direttamente lo stato energetico delle faglie, ci affidiamo a dati indiretti, come quelli astronomici analizzati dal modello EqForecast. Questo approccio individua condizioni necessarie, ma non sufficienti, all’innesco sismico. Il presente articolo tratta solo una parte del modello EqForecast, relativa alla stabilità e instabilità delle forze gravitazionali planetarie; ulteriori aspetti saranno approfonditi in successive pubblicazioni. Tuttavia, anche integrando tutte queste informazioni, il modello EqForecast non potrà mai fornire una previsione deterministica assoluta dell’evento sismico. Esso fornirà sempre un ventaglio di ipotesi riguardanti luoghi, tempi e magnitudo possibili, con finestre temporali di allerta che, sperimentalmente per terremoti con magnitudo superiore a 4.7 Richter in Italia, coprono circa il 3% dell’anno (approssimativamente nove giorni), durante i quali l’evento potrebbe verificarsi. Pertanto, il modello genererà inevitabilmente alcuni falsi alert, ma l’evento sismico avverrà verosimilmente all’interno del ventaglio ipotizzato.
4. Dalla teoria alla previsione probabilistica
Il modello EqForecast, combinando dinamiche astronomiche e fisica delle faglie, consente di individuare finestre temporali critiche per l’innesco sismico.
Utilizzando calcoli basati sulle orbite planetarie e sulla relativa variazione della forza gravitazionale risultante, EqForecast identifica i momenti esatti in cui questa forza, essendo particolarmente stabile o instabile, può determinare un innesco sismico.
Non si tratta quindi di una semplice previsione probabilistica, ma di un approccio deterministico fondato sul metodo sperimentale galileiano: attraverso lunghi cicli di osservazioni ripetute, il modello ha individuato una legge precisa che collega specifiche configurazioni astronomiche con eventi sismici passati, consentendo così di prevedere, con elevata affidabilità, le finestre temporali in cui il rischio sismico è concretamente maggiore rispetto alla media storica.
Il sistema può essere integrato con strumenti sismologici tradizionali per rafforzare il monitoraggio e la prevenzione in aree ad alto rischio.
Vedi anche:
Note bibliografiche
¹ Calandra, S., & Teti, D. (2024). Correlation Study: Triggering and Magnitude of Earthquakes in Italy (≥ M4.3) in Relation to the Positions and Gravitational Forces of the Sun, Moon, and Planets Relative to Earth. NCGT – New Concepts in Global Tectonics Journal, 12(1), 26–52.
https://users.neo.registeredsite.com/6/9/1/18560196/assets/NCGTJournalV12N1Pub24435.pdf#page=28; DOI: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15806.29762
² Zaccagnino, D., Vespe, F., & Doglioni, C. (2020). Tidal modulation of plate motions. Earth-Science Reviews, 205, 103179. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103179
³ Riga, G. (2015). Il terremoto de L’Aquila di M 6.1 e i suoi precursori sismici. Disponibile su Academia.edu: https://www.academia.edu/14544250/Il_terremoto_de_LAquila_di_M_6_1_e_i_suoi_precursori_sismici
Per approfondire
Chi desidera approfondire può leggere il libro divulgativo dell’autore del presente modello, disponibile al link:
https://www.earthquakesforecast.com/Libro_EqF_approved_Albatros.pdf
L’elenco completo delle pubblicazioni dell’autore è disponibile tramite il suo profilo ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-5324-2298